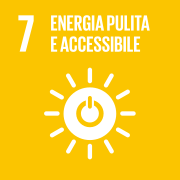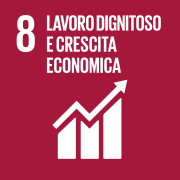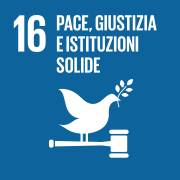Verso un nuovo modello energetico europeo
Nel cuore dell’agenda politica europea, già da molti anni, si è imposta una visione che punta alla creazione di un sistema produttivo ed energetico che possa essere sostenibile, equo e resiliente. Un obiettivo ambizioso, sia sotto il profilo politico sia sotto il profilo applicativo che ha precisi obiettivi: contenere l’aumento delle temperature globali, ridurre la dipendenza energetica dai combustibili fossili e promuovere una crescita industriale compatibile con i limiti del pianeta.
In questo contesto che l’Unione Europea ha dato origine a due framework strategici e normativi: il Green Deal europeo, lanciato nel 2019 dalla Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen; e il pacchetto legislativo “Fit for 55”, varato nel 2021, come traduzione normativa degli obiettivi strategici promossi dal Green Deal, con azioni e obiettivi specifici da raggiungere entro il 2030 per la salvaguardia dell’ambiente. Sono due tappe di un medesimo percorso che punta a ridisegnare il modello di sviluppo continentale secondo i principi della sostenibilità intrecciati con quelli dell’innovazione tecnologica, ma che subisce anche i contraccolpi dovuti alle crisi economiche e geopolitiche già in atto o che si stanno rapidamente profilando all’orizzonte.
Il Green Deal europeo: la visione strategica
Fin dalla sua introduzione nel 2019, il Green Deal ha rappresentato un mezzo di trasformazione economica e sociale: non si tratta soltanto di una proposta di politica ambientale, ma di un piano sistemico per rendere l’Europa il primo continente a “emissioni nette zero” entro il 2050.
Il cuore della proposta è quello di giungere alla separazione tra la crescita economica e l’impatto ambientale che ne deriverebbe, il tutto sostenuto da una transizione digitale in grado di abilitare nuovi modelli produttivi, di consumo e di governance.
Tra le direttrici principali del Green Deal vi sono la promozione dell’economia circolare, la decarbonizzazione del sistema industriale, il rafforzamento della mobilità sostenibile e un massiccio investimento sulle energie rinnovabili. Parallelamente, con il Just Transition Mechanism, l’Unione Europea ha scelto di dotarsi anche di uno strumento pensato per sostenere le regioni e i settori economici e sociali più esposti agli effetti della transizione, così da garantire equità sociale ed evitare l’emarginazione di cittadini e lavoratori più vulnerabili.
Fit for 55: tradurre in norma la transizione
Come si è detto, se il Green Deal è la cornice strategica il “Fit for 55” è invece l’insieme di tutte quelle misure che ne rappresentano la concreta articolazione legislativa a livello comunitario. In altre parole, la cornice normativa nella quale dare attuazione e conformare la visione originaria del Green Deal. Concepito nel 2021, questo insieme di norme deve il suo nome all’obiettivo stesso che punta a raggiungere, ovvero ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, con l’obiettivo finale di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
Ma si tratta di un traguardo che per essere raggiunto richiede l’approvazione progressiva di una serie di norme sempre più sfidanti (le prime varate nel 2022 e nel 2023). Queste comportano radicali cambiamenti per i sistemi produttivi e sociali dell’Europa intera che i singoli Stati membri sono poi chiamati a declinare a livello nazionale.
Tra i circa quattordici “macro-provvedimenti” contenuti nel quadro normativo “Fit for 55” ve ne sono alcuni considerati prioritari, come: la revisione del sistema ETS (il mercato delle quote di emissione), l’estensione della carbon tax alle frontiere (CBAM) per evitare il fenomeno del carbon leakage, l’accelerazione nell’elettrificazione del parco veicoli (fino allo stop alla vendita di auto a combustione interna nel 2035), e poi nuovi target vincolanti per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili. A questi si aggiungono le norme in materia di incentivi all’adozione di carburanti a basso contenuto di carbonio, e quelli per lo sviluppo delle relative infrastrutture, oltre ai pacchetti di misure per singolo settore dei trasporti: “ReFuelEU Aviation” per i nuovi carburanti nel settore dell’aviazione e il Regolamento “FuelEU Maritime” per il settore marittimo.
Tecnologie digitali e industria: un’alleanza necessaria per la transizione
L’attuazione del Green Deal e del Fit for 55 sta imponendo al sistema produttivo europeo una riconfigurazione strutturale senza precedenti. Non si tratta semplicemente di migliorare le performance ambientali delle imprese, ma di ripensare drasticamente l’intera catena del valore industriale alla luce di nuovi vincoli ecologici, normativi ed energetici. Alcuni settori più di altri stanno attraversando i processi radicali di trasformazione per la decarbonizzazione, con sfide complesse in termini di tecnologie, costi e tempi di implementazione.
In questo scenario il ruolo del settore ICT si fa decisivo perché le piattaforme di data analytics, le smart grid, i sistemi di automazione e la sensoristica ambientale sono oggi strumenti imprescindibili per rendere le infrastrutture energetiche più intelligenti e resilienti. Inoltre, l’adozione di soluzioni basate su blockchain e tecnologie DLT per la certificazione delle fonti rinnovabili e la tracciabilità della supply chain, apre nuovi orizzonti sia sul fronte della compliance sia in termini di trasparenza ed engagement dei consumatori.
È evidente che la sola leva regolatoria a livello europeo o nazionale non basta per rendere efficace una transizione così “radicale”: per questo è necessario intrecciare la transizione energetica con l’innovazione digitale – dove digitale e sostenibilità si alimentano a vicenda.
In ambito di transizione energetica in senso stretto, tecnologie come l’idrogeno verde, la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCUS), l’elettrificazione dei processi produttivi ad alta temperatura e l’impiego di materiali a basso impatto ambientale, rappresentano le fondamenta di una innovazione industriale in una prospettiva di “emissioni zero”. Tuttavia, l’adozione di queste e altre soluzioni, dipende fortemente anche dallo sviluppo di infrastrutture intelligenti così come dalla gestione efficiente dei dati e da un ecosistema digitale competitivo.
In questa prospettiva il settore ICT si configura come un abilitatore trasversale di soluzioni per la decarbonizzazione industriale, fornendo soluzioni e strumenti che ne migliorano l’efficienza, abilitano nuovi modelli di business e supportano il monitoraggio continuo degli obiettivi di sostenibilità. Alcuni ambiti nei quali la tecnologia funge da abilitatore di soluzioni per la sostenibilità riguardano:
– i Data analytics e l’Intelligenza Artificiale: per l’ottimizzazione energetica in tempo reale, il rilevamento precoce di anomalie nei cicli produttivi e la simulazione di scenari di consumo ed impatto ambientale;
– i Digital Twin: gemelli digitali per replicare virtualmente gli impianti industriali, prevedendo l’effetto (attraverso delle simulazioni) di modifiche operative o di investimenti infrastrutturali prima della loro reale implementazione;
– le Smart grid e l’IoT: Internet della cose per connettere le imprese a delle reti energetiche dinamiche, facilitando la flessibilità dei carichi, ma favorendo anche l’autoconsumo e l’interazione con fonti rinnovabili distribuite in rete;
– la Blockchain e le tecnologie DLT: tecnologie basate su archivi distribuiti (Distributed Ledger Technology) per certificare l’origine dell’energia utilizzata, garantendone la tracciabilità e migliorando la trasparenza lungo la supply chain, oltre che favorendo così le nuove soluzioni per la produzione ed il consumo decentralizzato di energia.
Il digitale per la governance e l’adeguamento normativo dei settori dell’energia e dell’industria
L’attuazione della transizione energetica e ambientale secondo gli standard voluti dall’Unione Europea non è solo questione di tecnologie e investimenti, ma anche di governance e inclusione. Oggi i meccanismi di data governance già consentono alle imprese di raccogliere, interpretare e condividere le informazioni sull’impatto ambientale dei propri prodotti e servizi. Parallelamente, anche la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e l’interoperabilità tra sistemi consentiranno sempre di più un monitoraggio efficace delle politiche energetiche, potenziandone così la programmazione e la valutazione.
La digitalizzazione non offre quindi soltanto delle soluzioni per il ripensamento delle filiere produttive, ma anche nuovi strumenti per la governance della transizione da parte delle Istituzioni oltre che per le politiche di trasparenza e compliance delle imprese.
Questi aspetti sono fondamentali nell’adeguamento alla normativa comunitaria e nelle pratiche di adozione degli standard ESG sia per le imprese del comparto energetico sia per quelle del comparto industriale e manifatturiero. Governare la transizione energetica adeguandosi alle normative contenute nel “Fit for 55” significa, ad esempio, adottare soluzioni ICT avanzate per meglio rispondere alla nuova normativa sul mercato delle quote di emissioni ETS; ma significa anche tracciare la propria filiera di importazioni dall’estero, dato che l’entrata in vigore del CBAM (meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere) non consentirà più alle imprese europee di esternalizzare i “costi” della transizione energetica.
Quale futuro per la transizione europea?
La traiettoria che dal Green Deal arriva al “Fit for 55” è un percorso di grande trasformazione che guarda con ottimismo al futuro, tuttavia sul continente europeo e sulle sue scelte in materia di sostenibilità energetica e industriale si stanno allungando le ombre di crisi geopolitiche e geo-economiche che rischiano di comprometterne l’attuazione. Se fino a qualche anno fa il Green Deal Europeo pareva rappresentare addirittura una leva strategica per la politica estera europea, il conflitti tra Russia e Ucraina e il nuovo corso politico di Stati Uniti e Cina, hanno rimesso tutto in discussione.
Il controllo di gran parte della catena del valore nel settore delle rinnovabili da parte delle industrie cinesi, ha spinto l’UE all’adozione di norme che favoriscono la rilocalizzazione delle produzioni green tech nel continente europeo, in particolare grazie all’adozione del Net-Zero Industry Act e del Critical Raw Materials Act, ma l’attuazione e gli effetti di tali norme richiedono tempi lunghi.
Allo stesso modo con il piano “REPowerEU”, Bruxelles è riuscita ad arginare gli effetti del crollo di forniture di gas dalla Russia dopo l’inizio della crisi ucraina, tuttavia, alcuni Stati come Germania e Polonia hanno dovuto fare ricorso per approvvigionamento energetico alla riapertura di vecchie centrali elettriche a carbone. Tutto ciò ha rafforzato le preoccupazioni di molti in materia di sicurezza energetica, e di “transizione giusta” intesa come sostenibilità socio-economica di tali scelte, tanto da comportare la revisione di alcune misure contenute nel “Fit for 55”.
Sono già oggetto di revisione, in particolare, quelle relative allo stop ai motori endotermici delle autovetture entro il 2035 (su sollecitazione di Italia e Germania) e le norme relative alla maggiore tassazione dell’energia prodotta da fonti fossili, per evitare che tali “disincentivi” fiscali si ripercuotano troppo duramente sui consumi di famiglie ed imprese in questa particolare congiuntura.
Se da un lato il percorso è irto di ostacoli, dall’altro è anche ricco di opportunità facendo potenzialmente dell’Europa un leader globale dell’innovazione sostenibile grazie alla propria capacità normativa, industriale e tecnologica. Per riuscirci, sarà fondamentale continuare a integrare tra loro le dimensioni della digitalizzazione e della sostenibilità per un progresso che renda il cambiamento del sistema energetico della nostra parte del pianeta più efficiente, pulito ed equo. È possibile che le norme del “Fit for 55” richiedano adeguamenti e tempi più lunghi per la loro piena attuazione, tuttavia, oggi rappresentano l’unico percorso possibile messo in atto da una così ampia comunità politica come l’UE rispetto alle sfide globali che tutti noi siamo chiamati ad affrontare.