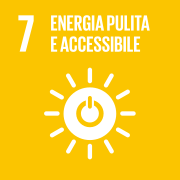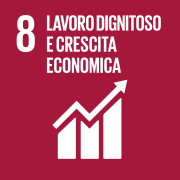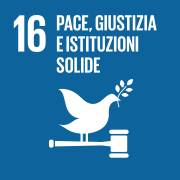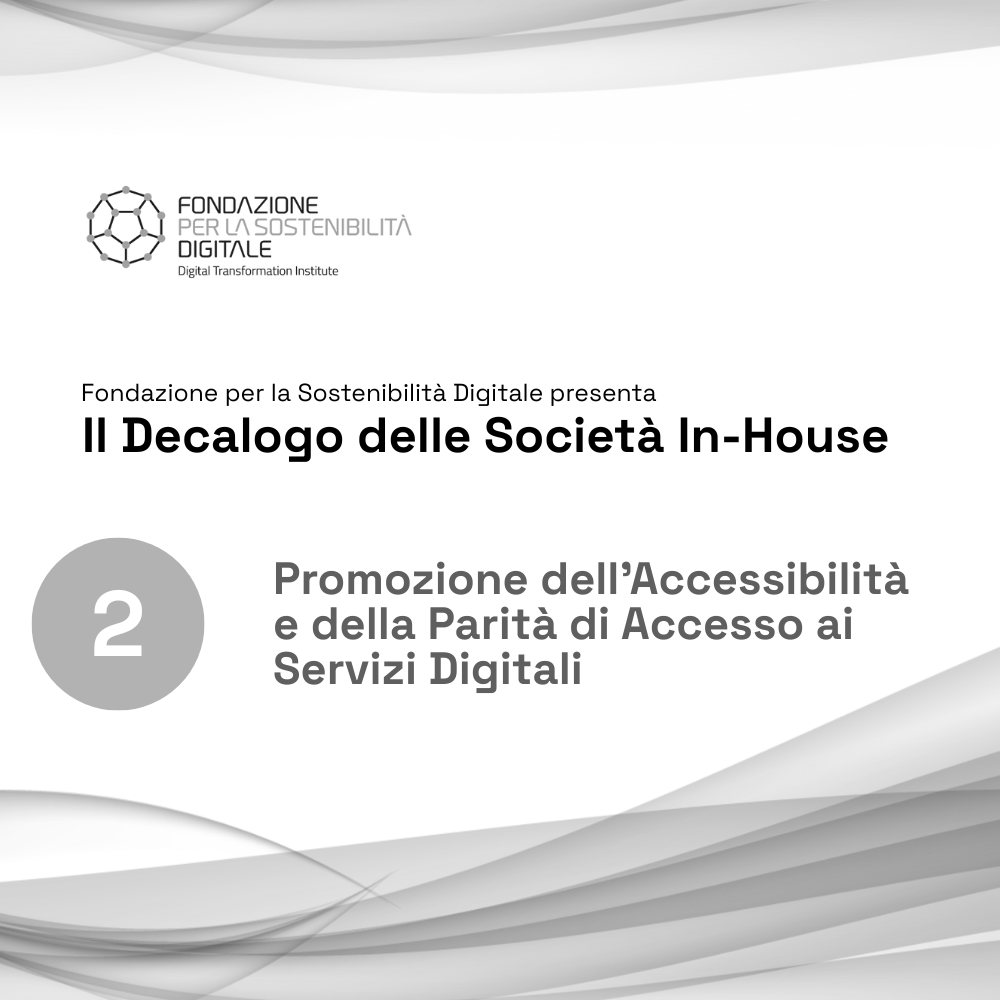
Una società in house ha come scopo la massimizzazione dell’efficacia dell’azione della propria amministrazione controllante. Questa impostazione è molto lontana da quella di una società che ha come scopo la massimizzazione dell’utile o l’aumento dei ricavi, poiché in questo caso l’obiettivo è massimizzare l’equità dell’azione che la pubblica amministrazione esercita sui propri utilizzatori, cioè i cittadini, garantendo che la tecnologia sia disponibile a tutti, affinché tutti abbiano un accesso equo.
L’impatto sociale di questa impostazione è fondamentale: non si tratta infatti di fornire a tutti la stessa tipologia di servizio, ma di fare in modo che tutti possano fruire allo stesso livello del servizio erogato, colmando quei gap che il singolo utilizzatore potrebbe avere rispetto all’utilizzo previsto. Ci troviamo quindi a dover colmare divari di varia natura, che possono andare da divari infrastrutturali, a differenze nei dispositivi di accesso, fino agli aspetti culturali legati alla funzione a cui si sta accedendo. Bisogna innanzitutto chiarire che un accesso egualitario ha un costo molto più elevato rispetto ad un accesso minimo garantito, poiché in quest’ultimo conta principalmente la soglia che si vuole mettere a disposizione di tutti i soggetti, mentre nell’accesso egualitario conta il divario tra la condizione del singolo e il livello di servizio desiderato.
È assolutamente evidente che, in tale situazione, il livello al quale si vuole arrivare è pensabile soltanto in ambito pubblico, dove lo scopo è sociale e non è legato a parametri rigidamente economici. In questo senso, le società in house sono gli unici soggetti con la necessaria competenza tecnologica, capaci di garantire l’eguaglianza, misurando da un lato il gap da colmare e dall’altro implementando le azioni tecnologiche più adatte per ciascun cittadino.
Si tratta quindi di un sistema che se volessimo andare a classificare nel mondo industriale, sarebbe assimilabile all’industria 4.0: un modello fortemente focalizzato sulla misurazione puntale delle esigenze e al superamento della singola esigenza specifica rispetto ad una volontà generica. Avere servizi digitali sostenibili, in questo caso, significa costruire in modo condiviso sia gli strumenti per misurare il gap puntuale, sia quelli per superarlo, inserendoli in una logica complessiva che consenta, nella moltitudine dei cittadini serviti, di generare un’economia di scala complessiva non realizzabile in ambito privato o comunque limitato nel numero dei soggetti da considerare.
Quanti siano i servizi digitali ai quali bisogna far riferimento non è definibile a priori e non lo sarà mai. Questo sia per un criterio di innovatività, che comporta l’individuazione continua di nuove strategie e orizzonti, sia per la naturale dipendenza che la società in house ha dal proprio controllore, il quale può definire strategie di natura politica variabili nel tempo, ponendo enfasi su parametri differenti.
Risulta particolarmente rilevante considerare che esistono territori con diverse disponibilità economiche. Ad esempio, si registra un divario significativo sui redditi medi pro capite tra le aree urbane e quelle rurali, così come fra le zone di pianura e quelle di montagna.
In generale, la sfida più complessa è fornire servizi ai luoghi più isolati o con minore densità abitativa, dove i costi medi sono più elevati rispetto alle aree densamente popolate.
Si configura, quindi, un doppio gap: da un lato, la maggiore complessità logistica nel raggiungere le zone marginali; dall’altro, il fatto che proprio in queste zone i redditi medi siano spesso inferiori. La stessa dinamica si riscontra andando a rilevare la percezione dell’importanza del digitale di tali territori, così come nella propensione ad effettuare azioni che massimizzano la sostenibilità digitale, sia da parte delle amministrazioni che da parte dei singoli cittadini.
Tutto ciò evidenzia come il ruolo di una società in house sia particolarmente strategico, poiché, avendo soci pubblici, può armonizzare situazioni differenti territorialmente sulla base della propria esperienza. Inoltre, qualora vi siano enti sovraordinati che abbracciano sia aree marginali che meno marginali, la società in house è in grado di orientare maggiori investimenti verso i territori più decentrati, contribuendo così a mantenere una visione equa dell’intero sistema territoriale.
Si tratta quindi di fare in modo che vi sia parità di accesso sia tra soggetti diversi che tra territori differenti. Ancora una volta, riteniamo che una società in house, con la capacità di abbracciare una molteplicità di utenti e di amministrazioni, innanzi allo scopo di portare la massima equità di accesso, possa rappresentare una chiave vincente per raggiungere questo intento, anche nell’ottica di un’economia complessiva e di filiere capaci di gli impatti a livello sistemico.
Si citano alcuni esempi che possono chiarire questa filiera sotto il profilo infrastrutturale. Ad esempio, portare connettività nei luoghi montani comporta sicuramente un costo legato agli scavi molto maggiore rispetto alle zone di pianura, a causa dell’orografia del territorio, della presenza di rocce e di un maggior numero di difficoltà realizzative rispetto alla pianura.
Queste zone avrebbero un palese fallimento di mercato e laddove tale fallimento comporti un’indisponibilità tecnologica nei confronti dell’utenza, è qui che risulta assolutamente fondamentale il ruolo sussidiario della pubblica amministrazione.
Quest’ultima deve riportare in queste zone una condizione analoga a quella dei territori già serviti, costruendo in proprio le infrastrutture che il mercato non è incentivato a realizzare. Inoltre, è importante mettere tali infrastrutture a disposizione del mercato a cifre che siano assolutamente analoghe, se non inferiori, a quelle delle zone più servite per incentivare gli investimenti sussidiari e per favorirne l’utilizzo in luoghi dove questo non avviene nativamente.
Un altro esempio è legato alla capacità di utilizzo del digitale da parte della cittadinanza.
Molte amministrazioni si sono impegnate nel costruire corsi con vari livelli di ingresso, per cercare di creare una competenza digitale il più possibile omogenea.
Tali corsi sono pensati per permettere di fruire sia dei servizi della pubblica amministrazione sia, in generale, di tutti i servizi che il digitale oggi propone, i quali rappresentano palesemente un meccanismo di socialità da un lato e di intrattenimento dell’altro.
Una discussione storica è legata a quanta banda occorra garantire ad ogni cittadino, per fare in modo che, ovunque si trovi, non sia mai discriminato rispetto ai luoghi meglio serviti. La discussione non è assolutamente facile perché dipende dal tipo di servizio. Tuttavia, un’idea di massima può essere realizzata, andando ad ipotizzare uno scenario di realtà immersiva virtuale nel quale la percezione dell’utente sia quella di vivere in un qualunque altro spazio, con l’estensione dei propri sensi nel luogo dove sta immaginando di essere. In questo caso, la banda necessaria è quella per realizzare una completa esperienza immersiva in cui, indipendentemente dai meccanismi di interfacciamento, non si perda vista, olfatto, gusto, tatto e suoni, cioè tutti i nostri cinque sensi, rispetto ad essere nel luogo virtuale nel quale si sta navigando.
Alcuni studi odierni dimostrano che una simile banda è dell’ordine di 100 Mbps e quindi assolutamente realizzabile con le tecniche attuali. Questo significa anche che, alla domanda “abbiamo sempre bisogno di più banda?” o “abbiamo sempre bisogno di qualcosa in più?”, ipotizzando che la banda di accesso sia uno degli elementi principali per garantire equità di accesso, la risposta diventa no. Esiste un limite e quando si raggiunge, un limite per persona e quindi personalizzato, si arriva ad una vera equità di accesso. In questo senso le società in house lavorano per costruire filiere di servizi di infrastrutture che sfidino questi limiti, da un lato valutandoli e dall’altro realizzandoli.